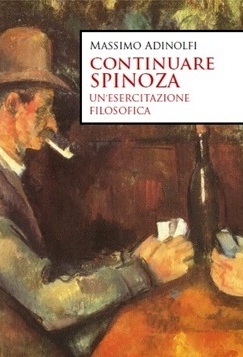È o non è il governo del cambiamento? E allora, se è il governo del cambiamento, gli scienziati che siedono nel Consiglio superiore della sanità possono accomodarsi alla porta. Si cambia anche lì. È prerogativa del ministro della Salute, Giulia Grillo, nominare nuovi consiglieri? E allora la prerogativa viene esercitata, con o senza interlocuzione con la comunità scientifica (più senza che con, per la verità) e i vecchi consiglieri vanno a casa. Non diversamente il collega all’Istruzione, Bussetti, si era regolato con il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Battiston: fuori pure lui. Poi però il ministro doveva pensare al successore, e lì le cose si sono complicate alquanto, poiché, a detta degli esperti che lavoravano al bando, dal ministero si volevano allentare un po’ troppo i criteri per individuare il nuovo nome, e così sono fioccate le dimissioni. In blocco. Il governo del cambiamento da una parte, gli accademici da un’altra.
Qualche mese fa Davide Barillari, consigliere regionale pentastellato nel Lazio, nel bel mezzo della polemica sull’obbligatorietà dei vaccini, aveva posto retoricamente la domanda decisiva: «quando si è deciso che la scienza è più importante della politica?». Già, quando? Ora i ministri del nuovo governo stanno chiarendo il significato di quella domanda, e soprattutto le sue pratiche conseguenze. Se la scienza non può essere più importante della politica, ma deve essere a quella subordinata, allora il ministro esautora, nomina o estromette come meglio gli aggrada.
E può giustificare la decisione, al di là della sua legittimità formale, in nome della «scienza democratica» alla quale inneggiava Barillari. Ma la scienza – domando – è davvero democratica? Si vota forse a maggioranza, tra gli scienziati, cosa fa il neutrino, o cosa ti combina un farmaco? Evidentemente no. Perché non è affatto questione di chi sia più importante, se la politica o la scienza, ma, semmai, di quella distinzione che faceva già Aristotele, alle origini della politica occidentale, tra le cose sulle quali ha senso deliberare (e lì ne va della politica, evidentemente), e le cose su cui non ha alcun senso deliberare perché stanno come stanno, e non ci puoi fare niente (e lì è meglio che la politica resti fuori, sennò combina solo disastri). La modernità si è abituata a ritenere – credo proprio a ragion veduta – che in questo secondo genere di cose rientrino le risultanze scientifiche, sulle quali dunque la politica non ha, o non dovrebbe avere, nulla da dire (da decidere e da votare). E invece dall’omeopatia agli ogm, dalla Xylella ai vaccini, dalle malattie portate dagli immigrati ai dibattiti sulle fonti di energia, non sembra vi sia più alcuna questione su cui si possano esibire evidenze sperimentali, o anche solo qualche pacifico dato di fatto. Non siamo, del resto, nell’epoca dei fatti alternativi e della post-verità?
Alla modificazione della sfera pubblica, per cui oggi è possibile, nel mare magno della Rete, trovare conferma alla più strampalata delle teorie, si aggiungono, nel populismo che ci governa, un altro paio di ingredienti mica da poco. Il primo è una profonda sfiducia nei confronti di quel mondo istituzionale nel quale i nuovi governanti hanno messo piede per la prima volta. Non importanti quali istituzioni finiscano nel mirino: anche se si tratta di tecnici, di esperti, o di scienziati, lavorino all’Economia, alla Salute o all’Istruzione, parliamo di un personale che svolge anche compiti amministrativi e gestionali, consultivi e non solo, e di cui dunque si diffida in principio: sono Casta pure costoro, e nessun curriculum li proteggerà.
Il secondo è una evidente immaturità democratica, una chiara insofferenza nei confronti delle molte istanze che compongono il tessuto complesso di una società plurale. Nella semplificazione populista, chi detiene il potere politico decide: punto e basta. Vedersi opporre un «non si può fare» suona come un’intollerabile limitazione dell’esercizio democratico della sovranità. Anche se ad opporre un rifiuto è, a volte, la realtà stessa.
Poi, certo: c’è la debole cultura scientifica del nostro Paese. Ma per una volta eviterei di scomodare la polemica crociana sugli pseudoconcetti, o le tirate marxiste contro la scienza borghese, la presunta dittatura dell’idealismo o la cappa spiritualista della tradizione cattolica: sarebbe fare troppo onore a faccende molto più modeste, a volte persino penose. Se proprio si vogliono trovare radici, saranno in un certo ecologismo, in un certo anticapitalismo, e in una presunta democratizzazione delle competenze che ne produce, in realtà, l’azzeramento.
Ed è un peccato, perché tutto sta cambiando, e l’impatto delle tecnoscienze sulla vita umana, individuale e sociale, richiederebbe ben altra attenzione, da parte della politica e del mondo intellettuale. E invece, alla fin fine, siamo semplicemente alla sostituzione di tecnici e consiglieri, per ragioni di bottega, di consorterie e di camarille varie.
(Il Mattino, 5 dicembre 2018)