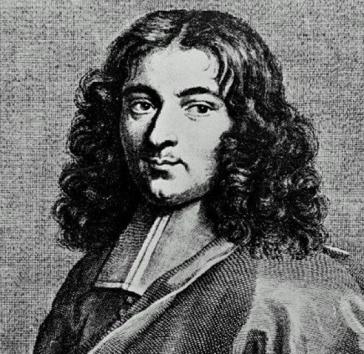
A un certo punto venne fuori questo ragionamento: la fede cristiana predica la misericordia, la bontà e il perdono, ma un conto è la fede cristiana, un altro sono i cristiani in carne ed ossa. Quanto a questi ultimi, chi non li conoscesse avrebbe bisogno di vivere non più di quindici giorni in mezzo a loro per sapere che non seguono affatto i principi in cui dicono di credere. Tra il dire e il fare…
A qual punto, però, venne fuori questo ragionamento? Al punto in cui lo mise Pierre Bayle, nei paragrafi 133 e seguenti dei suoi Pensieri diversi sulla cometa. Siamo nel 1682 e i pensieri di Bayle sono tra i primi segnali della nuova mentalità che nel secolo successivo, con l’illuminismo, si spanderà per l’intera Europa. Dopo più di tre secoli, non facciamo molta fatica ad essere d’accordo con Bayle, né desta scandalo la conclusione che Bayle trasse da quei suoi pensieri, che cioè è ben possibile una società di atei virtuosi, di gente che non crede in Dio e non va a messa la domenica e però si comporta bene: «Ora è quanto mai chiaro e evidente – concluse infatti – che una società di atei si comporterebbe in maniera civile e morale proprio come qualsiasi altra società».
Un conto è però se a trarre conclusioni simili è un polemista francese di famiglia protestante, un altro è se è invece il Papa della Chiesa cattolica romana. Beninteso: i tre secoli sono passati anche per Roma, e non è certo una novità dottrinale quella introdotta da Papa Francesco. Però fa lo stesso un certo effetto ascoltarlo nel corso dell’udienza generale mentre dice: «Quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e stanno lì tutta la giornata o vanno tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri o parlando male della gente. Questo è uno scandalo! Meglio non andare in chiesa: vivi così, come fossi ateo. Ma se tu vai in chiesa, vivi come figlio, come fratello e dà una vera testimonianza». Meglio ateo che cattivo cristiano, insomma. Ovviamente, è facile per noialtri essere d’accordo con il Papa, su questo punto. Facile per quanti si sono già allontanati da tempo dagli aspetti rituali della fede religiosa. E naturalmente ancor più facile per tutti coloro che non hanno la fede, vivono in una dimensione laica e secolarizzata, e che – ancor prima che Francesco ne parlasse – erano già convinti che fra compiere una buona azione e osservare il precetto della messa domenicale fosse più importante la prima cosa. Ma per i cristiani praticanti, per quelli che ricevono i sacramenti e vivono nella comunità ecclesiastica, è un po’ meno facile. Perché il rischio è che non si comprenda più bene che cosa la religione abbia e dia in più rispetto alla morale. Se anche per il Papa sono sufficienti le opere, le buone azioni, e soprattutto «non odiare la gente», allora perché continuare a confessarsi, o a prendere la comunione? È un ben strano supplemento, il sacramento religioso, visto che può persino rivelarsi superfluo, dal punto di vista di ciò che si richiede a un uomo per vivere rettamente.
Quella dei rapporti fra morale e religione è una faccenda assai complicata: se la religione si riduce a morale, allora non si capisce a che serva tutto l’apparato istituzionale che vi è cresciuto sopra. Cristo dice a Pietro che su di lui costruirà la sua Chiesa: ma cosa l’ha costruita a fare? Se invece la religione offre qualcosa di più della morale (per esempio: una salvezza riservata esclusivamente ai propri fedeli) allora tornerà ad essere complicato preferire l’ateo buono al cristiano ipocrita (e l’autorità morale della Chiesa non potrà più valere universalmente, per ogni uomo in quanto uomo).
Non sono ovviamente questioni che si pongano per la prima volta con Papa Francesco: è infatti dai pensieri di Bayle che se ne parla. E in verità anche da prima, solo che gli scritti di Bayle si situano effettivamente su un crinale della coscienza europea, che si fa in quei decenni moderna, laica, razionale. Dopo di allora, è tutto il lessico del sacro, della fede, della grazia, del sacerdozio, del miracolo, che si mette in cerca di nuove giustificazioni, per tentare di resistere alla lenta consumazione del religioso ad opera dell’istanza morale. E però tutto il pontificato di Francesco sembra oggi mettersi sotto l’accento della morale, della carità e della misericordia cristiana come opera dell’uomo verso l’uomo, in una luce tutta laica, così laica appunto da essere preferita ad ogni sorta di omaggio ipocrita nei confronti della fede.
Cos’altro dovrebbe dire, però, il Papa? Non è così che la sua parola può farsi vicina e comprensibile all’uomo contemporaneo? Forse sì. Però è possibile misurare la novità che si viene producendo solo ricordando come siano rimbalzate di recente altre parole, spese agli inizi della modernità. Quelle di Grozio: etsi Deus non daretur. Facciamo come se Dio non ci fosse, diceva Grozio, per trovare un accordo laico fra gli uomini e vivere in pace. A riprenderle, e a ribaltare, è stato Benedetto XVI, che, tutt’al contrario, ha invitato anche chi non crede a vivere «come se Dio ci fosse»: una scommessa (su cui pure Blaise Pascal invitava a puntare) che provava a capovolgere, o almeno a resistere, all’impetuoso cammino di secolarizzazione intrapreso dall’Occidente. Le parole di Francesco – meglio vivere come si fosse atei, che dare scandalo con una fede ipocrita – sono letteralmente agli antipodi dell’invito di Ratzinger. Però è anche vero che, con esse, la resistenza che viene opposta alla secolarizzazione semplicemente si azzera. E la Chiesa pellegrina, aniziché opporsi al mondo, rischia sempre di più di confondersi con esso.
(Il Mattino, 3 gennaio 2019)

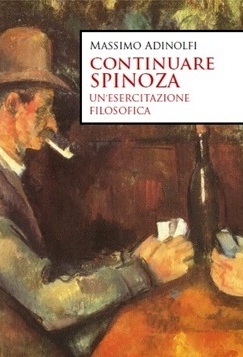
Perché questo assist, non so quanto involontario ma sicuramente “oggettivo”, a quei cattolici conservatori che vedono Francesco come il fumo negli occhi? Se fosse vero che con le sue parole “la resistenza che viene opposta alla secolarizzazione semplicemente si azzera”, allora il primo da ritenere incoerente sarebbe lo stesso Gesù Cristo quando se la prendeva con i sepolcri imbiancati, quando ammoniva i farisei ricordando loro che i pubblicani e le prostitute li precedono nel regno dei cieli, quando osservava che non chi dice “signore, signore” entrerà nel regno dei cieli ecc. ecc. L’importante è che vi sia, appunto, un regno dei cieli, ed è questa ovviamente la grande differenza rispetto a qualunque prospettiva “secolarizzata”. Che poi nel regno dei cieli possa entrare benissimo anche chi in questa vita non ci credeva e non ci sperava, e possa invece esserne escluso qualcuno di coloro che se ne sono continuamente riempiti la bocca, questa è la novità del messaggio cristiano rispetto a una religiosità di tipo puramente tradizionale, ma di per sé non è affatto secolarizzazione nel senso di ateismo o di pura e semplice risoluzione della religione nella morale…
Gli ammonimenti del Papa non mi sembrano venire quasi mai da un piedistallo intellettuale. Mi sembrano piuttosto nell’ordine degli ammonimenti del tipo, “chi ha orecchie per intendere intenda”. Credo, infatti, che uno dei grandi contributi di questo Papa nella nostra società sia proprio la sua posizione anti-intellettualistica su molti temi. Grazie per l’articolo.