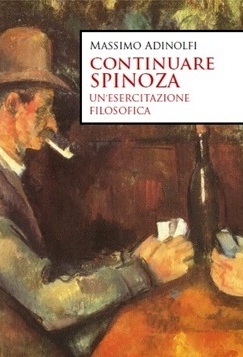La verità sull’immigrazione. Non è facile, ma è necessario. I toni populisti e forcaioli rendono difficile proporre un ragionamento serio; i rischi dell’equivoco, oppure della strumentalizzazione si nascondono dietro ogni parola, e tuttavia non basta prendersela con chi soffia sul fuoco o lucra sulla paura, senza domandarsi perché il fuoco covi sotto la cenere, e come mai sia possibile condurre un simile gioco. Vi sono aspetti generali del fenomeno difficilmente governabili, e vi è sicuramente una responsabilità dell’Europa che non può lavarsene le mani e lasciare soli i paesi più esposti, ma esposti – voglio chiedere – a cosa? All’ingresso di orde di barbari, di delinquenti incalliti, di razze geneticamente inferiori? Nulla di tutto questo, ovviamente. Ma è passato quasi un quarto di secolo da quando una nave di albanesi colma fino all’inverosimile si affacciò sulle nostre coste: cosa abbiamo fatto da allora perché fosse meno estraneo il volto dell’altro, e meno minaccioso? Quali politiche per l’immigrazione e per la sicurezza sono state attuate, e con che risultati? Quanto si può dire che sia riuscita l’integrazione degli extra-comunitari, e quanti di costoro, che sono qui ormai da anni, non sono più extra? A chi abbiamo dato la cittadinanza? A chi saremmo disposti a darla? E a quali condizioni la daremmo? Quali doveri pretendiamo noi, come Paese,d a un immigrato?
La verità sull’immigrazione. Non è facile, ma è necessario. I toni populisti e forcaioli rendono difficile proporre un ragionamento serio; i rischi dell’equivoco, oppure della strumentalizzazione si nascondono dietro ogni parola, e tuttavia non basta prendersela con chi soffia sul fuoco o lucra sulla paura, senza domandarsi perché il fuoco covi sotto la cenere, e come mai sia possibile condurre un simile gioco. Vi sono aspetti generali del fenomeno difficilmente governabili, e vi è sicuramente una responsabilità dell’Europa che non può lavarsene le mani e lasciare soli i paesi più esposti, ma esposti – voglio chiedere – a cosa? All’ingresso di orde di barbari, di delinquenti incalliti, di razze geneticamente inferiori? Nulla di tutto questo, ovviamente. Ma è passato quasi un quarto di secolo da quando una nave di albanesi colma fino all’inverosimile si affacciò sulle nostre coste: cosa abbiamo fatto da allora perché fosse meno estraneo il volto dell’altro, e meno minaccioso? Quali politiche per l’immigrazione e per la sicurezza sono state attuate, e con che risultati? Quanto si può dire che sia riuscita l’integrazione degli extra-comunitari, e quanti di costoro, che sono qui ormai da anni, non sono più extra? A chi abbiamo dato la cittadinanza? A chi saremmo disposti a darla? E a quali condizioni la daremmo? Quali doveri pretendiamo noi, come Paese,d a un immigrato?
Non sono domande difficili, eppure a molte di esse non possiamo che dare risposte molto parziali, lacunose, insufficienti. Manca infatti un quadro di regole soddisfacente che consentano un governo effettivo del fenomeno. Governarlo non può voler dire abolirlo: è impossibile, non si può fare. Ma non può voler dire nemmeno rinunciarvi del tutto, e pazienza se ognuno si dovrà arrangiare come può. La Lega, d’altra parte, può montare tutta la caciara che vuole, prendersela coi prefetti o coi magistrati, gridare al nemico alle porte e tirar su il ponte levatoio. Può farlo, incurante delle responsabilità che ha, per essere stata alla guida del Paese per anni, per avere avuto la titolarità del ministero dell’Interno, per avere firmato il Trattato di Dublino e la regola che lascia sulle spalle del paese d’arrivo (spesso l’Italia) tutto il peso dei migranti. Ma presa la distanza più netta e più radicale dalla insopportabile demagogia leghista, non è demagogico anche parlare di accoglienza, di ospitalità, di solidarietà, parlare ed avere fallito e fallire nell’opera di scolarizzazione, oppure utilizzare la pressione migratoria solo come esercito di riserva (magari illegale) della manovalanza meno qualificata?
Quale rapporto vi è fra le parole pur necessarie per svelenire il clima ed incoraggiare il reciproco rispetto (che è qualcosa più della tolleranza, cioè della sopportazione pura e semplice del diverso), quale rapporto vi è – dico – fra queste parole e le condizioni reali di convivenza che si danno nelle periferie delle nostre città, negli angoli delle strade dove li incontriamo: fantasmi che vorremmo non incrociare mai, spettri che ci assillano con la loro semplice presenza, estranei con i quali non sapremmo scambiare due parole? Finché non offriamo che questo: un modo di ammucchiarli in campi profughi, una specie di reclusione in centri di presunta accoglienza dove qualcuno monetizza oscenamente una pelosa solidarietà, e infine, il più delle volte, una condizione di clandestinità o di semi-illegalità, finché – ripeto – non mostriamo altro volto che questo, come possiamo pensare di educare loro e di educare noi stessi? La scommessa della multiculturalità non può essere vinta (benché la pressione migratoria sia tale che non sia possibile non giocarla), finché oscilla fra il relegare e l’ammassare, senza mai essere in grado di tracciare linee, stabilire norme, e soprattutto dire sì a questo e no a quello, visto che il no a tutto ingrossa solo le fila dei clandestini in terra e dei cadaveri in mare, ma anche il sì a tutto, senza politiche a sostegno, alla lunga produce risultati non molto diversi, anche se al riparo di una buona coscienza.
L’ospitalità è un dovere etico assoluto, incondizionato, che però ci interroga in quanto individui; la responsabilità politica è un’altra cosa, perché si estende anche agli individui che noi non siamo, alla cui fatica del vivere quotidiano non possiamo permetterci di aggiungere i nostri doveri etici inderogabili. Essere ospitali non può, allora, voler dire accettare che ad ogni crocevia di strade, nelle nostre città, la criminalità abbia modo di gestire il racket dei lavavetri e il commercio dei fazzoletti di carta.
L’altra sera ho perso l’ultimo treno da Roma: la stazione Termini chiude per qualche ora. Sono rimasto nel piazzale antistante, per qualche ora, e ho visto un’umanità dolente, povera, raccogliersi stancamente, quasi uscire dall’ombra e cercare di organizzarsi alla bell’e meglio un giaciglio con buste e cartoni, cercare l’acqua di una fontanella per una toilette di fortuna, fasciarsi i piedi, frugare nell’immondizia. In che senso – mi chiedo – in che modo queste persone sono accolte in Italia? Perché chiamare accoglienza la mera tolleranza di una simile condizione? Non vi è uno spaventoso equivoco, in tutto ciò? E chi vincerebbe una sola elezione – lo dico alla sinistra che su questi temi ha perso e rischia di perdere nuovamente la Capitale – se lasciasse le cose così, come si vedono la notte, nei pressi della stazione Termini? E cosa pensa di chiedere a chi vive non per una malaugurata notte ma ogni giorno e ogni notte fianco a fianco di situazioni simili? Cosa pensa di opporre alla retorica leghista? Dire «non li vogliamo a casa nostra» è sbagliato e ingiusto, ma dire «la mia casa è la tua casa» è ipocrita. Ed è invece tempo di verità, vi prego, sull’immigrazione.
(Il Mattino, 13 giugno 2015)